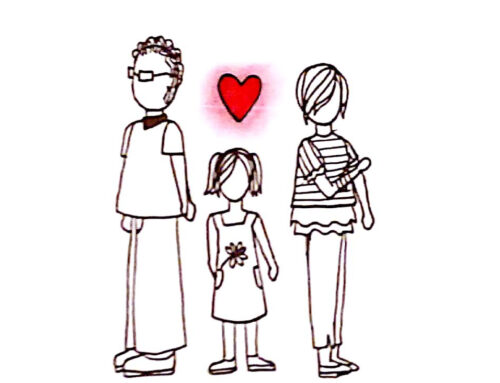In questi giorni molti sono stati i commenti all’ordinanza della Cassazione 13217/21 e altrettanti commenti sulla teoria della PAS, in essa riportata, hanno spopolato sul web.
Rimandando ad altro mio intervento la specificità del caso, mi interessava affrontare, in questo articolo, la facilità con cui molti “addetti ai lavori” riescono a misconoscere un fenomeno tanto studiato dalla psicologia come l’importanza che la relazione, inizialmente diadica poi triadica, sviluppata dal bambino con gli adulti di riferimento fin dalla sua nascita possa incidere sulle sue successive tappe evolutive, influenzandone l’apprendimento e lo sviluppo. Questo perché? Non di certo perché il bambino è da considerare “un fantoccio nelle mani dell’adulto” o perché “non in grado di portare avanti un proprio pensiero”, ma perché è attraverso quella stessa relazione che imparerà a conoscere il mondo e la realtà circostante e sarà quella stessa relazione che gli consentirà di sviluppare un senso di fiducia e di protezione che lo accompagneranno nelle relazioni future.
Ora, la domanda sorge spontanea: laddove si riconosca l’importanza e l’incidenza che questa relazione possa avere nella vita del bambino, laddove si riconosca il carattere accondiscendete del bambino rispetto all’adulto di riferimento in situazioni per lui complesse o difficili da comprendere, come si può continuare a negare l’esistenza del potere suggestionante dell’adulto nei confronti del bambino, in qualsiasi contesto essi possano trovarsi.
Seppur mi piacerebbe credere nel contrario, purtroppo non si può rinnegare l’esistenza di situazioni in cui i bambini si trovano, loro malgrado, inseriti in conflitti coniugali da quegli stessi genitori in cui ripongono fiducia e da cui si aspetterebbero protezione e amore incondizionato. Purtroppo, però, in questi casi non si può parlare in termini di fede o credenze, piuttosto di casistiche e situazioni professionali che non fanno che gridare giustizia e tutela del benessere del bambino prima ancora di quella genitoriale.
Questi i fatti, di fronte ai quali mi chiedo se veramente può esser ridotto tutto ad una questione di definizione! C’è questa bizzarra idea, infatti, che continuare a parlare di alienazione parentale possa, in qualche modo, incidere negativamente nel mondo psicoforense, ledendo (addirittura) l’intera categoria professionale. Sembra che il solo parlare di alienazione parentale susciti così avversione e disappunto, tanto da divenire quasi “l’Innominato” della psicologia, un essere malvagio e abominevole che ormai da anni si cerca di rinchiudere nelle Segrete per non compromettere il decoro della professione.
Mi chiedo, però, quanto dietro questa querelle si nasconda qualcos’altro, quanto di politico possa esserci in questa che sembra essere più una presa di posizione, un tentativo di strumentalizzare un fenomeno relazionale la cui importanza è sempre stata ben spiegata e studiata in tutte le più accreditate teorie psicologiche dell’età evolutiva.
Certamente le origini di AP non possono che essere riconducibili alla teoria della PAS di Gardner, la cui teoria, come ampiamente spiegato in diverse occasioni e pubblicazioni, si basava erroneamente su una medicalizzazione del bambino affetto da una sindrome la cui cura non sembrava neanche poi così chiara: può essere curata? È necessaria l’assunzione di farmaci? Bisogna subire qualche intervento medico? Nulla di tutto questo, ovviamente!
Di fatti, così come ogni teoria scientifica, anche la PAS ha subito dei cambiamenti, delle evoluzioni perché la scienza, per definizione, non può essere statica, ma in continuo divenire in quanto soggetta a continue ricerche, sperimentazioni e revisioni che, ad oggi, hanno fatto dell’alienazione un concetto ben più ampio e complesso, un fenomeno psicologico che pone al centro la relazione disfunzionale presente nel sistema familiare in separazione e che ha, come conseguenza ultima, un netto e categorico rifiuto del bambino nei confronti di un genitore senza di fatto alcuna motivazione. Una condizione psicologica che, in termini forensi, si esplica di fatto nella negazione del diritto del bambino alla bigenitorialità.
Mi chiedo se può ridursi veramente soltanto ad una questione di definizione o se il dibattito scientifico possa andare oltre, toccando con mano (e con co-scienza) il vero ed essenziale elemento importante di tutta la questione: al di là di come si voglia chiamarli, la messa in atto di questi comportamenti genitoriali disfunzionali, di fatto, incidono negativamente sullo sviluppo e sul benessere psicofisico del bambino, comportando seri danni psicologi all’adulto del domani.
Quanto può essere giusto disquisire su come chiamare o non chiamare un fenomeno, riconosciuto da tutto il mondo accademico, che spiega la necessità del bambino di assecondare, in condizioni specifiche chi, più di ogni altro, può dargli protezione e amore?
Chissà se, con il tempo, questo “Innominato” riuscirà a trovare una sua collocazione portando ad un dibattito più profondo e coscienzioso dell’argomento, andando a toccare le vere possibili soluzioni in termini di tutela del bambino, senza cadere nelle ormai classiche trappole psicologiche per cui si crede di far bene solo perché si va contro, seguendo la politica della “critica ad ogni costo” per riuscire ad elevarsi. Chissà se si riuscirà finalmente a perseguire un obiettivo comune come quello di salvaguardare il benessere psicofisico dell’individuo, lavorando “insieme a” e non “contro” per riuscire a raggiungerlo.